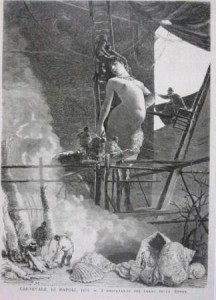Il 17 febbraio sarà la Festa Nazionale del Gatto. Alle mie belve di casa, che hanno adottato Skip vero stringendo con lui un’affettuosa amicizia da associazione a delinquere, allietata da allegre scorribande, ho dedicato qualche post che pubblicherò volentieri. Oggi vorrei ricordare i tanti gatti coi quali sono vissuta sin da bambina, prima a casa di nonna e poi a casa mia.
Vediamo da dove posso cominciare questa lunga saga felina.
La prima gatta della nonna, che ricordo, si chiamava Topa, però era una gatta. E io, a cinque anni, non riuscivo a capire perché mai si dovesse chiamare Topa; forse perché era colore orzo, mezza spelacchiata con occhi giallo senape. Amava molto ascoltare con il nonno le canzoni di Ornella Vanoni, trasmesse in tv.
La Gegia era una gatta che non si può definire una bella gatta. Aveva un pelo di un nero che sfumava nel viola. Invece di miagolare gnaognalava con una voce straziante Era molto indipendente e incuteva soggezione coi suoi grandi occhi gialli che brillavano al buio. Secondo me incarnava qualche monaciello, perché compariva e scompariva all’improvviso. A quel tempo c’era pure il bellissimo Bijoux, dal mantello vellutato d’argento con due occhioni verde smeraldo e il Rosso, famoso non solo per le prodezze venatorie ma anche per l’abilità a saltare sulle maniglie ed aprire le porte. Suo compagno era Caribù, cosiddetto per la folta pelliccia invernale,bianca con chiazze a strisce. Era il tipico gatto sornione che finge di non vedere e non sentire. Un giorno si addormentò dentro il focolare della cucina, che fungeva da inceneritore, e ne schizzò fuori bruciacchiato quando la nonna vi accese un piccolo falò. Fortuna volle che i suoi miagolii la indussero ad aprire lo sportello evitando così di cuocere un gattò al forno.
Sandrino invece era un maestoso gattone dal pelo lungo. Amico inseparabile della nonna, sedeva sul tavolo tondo quando lei ricamava e pareva ascoltarla quando inscenava scherzosi dialoghi, chiamandolo Signor Gatto. Ogni mattina condivideva con lei il latte corretto con il whisky che lo faceva ondeggiare sul davanzale. Grazie a lui imparai molto presto a fare la spesa, perché la nonna non gli faceva mai mancare papponi di riso e alici.
Indimenticabile è Zigo Zago, una panterina nera in miniatura con tondi occhi gialli, che mi faceva intonare a squarciagola il motivo “Ziiigo Zaaago , piccolo maaago”.
Molto più tardi arrivò Biòs (vita), una dolce micetta bianca. Fu chiamata così perché sottratta da mia zia al regno dei morti del cimitero. In verità era molto viva perché ben presto sfornò tre mici. In contemporanea il destino portò Bissi Bissi ,un micino bianco e nero che io e mia cugina estraemmo da un bidone della spazzatura, incuriosite dai suoi flebili lamenti. Temendo di portarlo a casa della nonna, già popolata di gatti, spesso abbandonati da ignoti sul portone di casa , lo nascosi in un deposito del giardino. Quando mia zia usciva per andare al lavoro, io andavo in giardino e gli somministravo latte diluito col contagocce. Il micetto poi imparò a camminare , seguendomi ovunque. Quando rientravo in casa, lo lasciavo nel deposito. Ma i piccoli mici crescono e quindi iniziò a esplorare i dintorni, venendo allo scoperto. Io e mia cugina confessammo l’accaduto e mia zia, apprezzando il nobile gesto, lo accolse nella tribù felina. Una volta tornò col pelo non più bianco,ma sporco e unto di grassa fuliggine, perché forse era andato a dormire su una caldaia. Così pensai bene di lavarlo. Lo pulii con estrema cautela per timore di un’artigliata, inizialmente con una spugna inumidita, poi osai immergerlo in una bacinella , piena di acqua e bagnoschiuma. È stato l’unico gatto di mia conoscenza, che non solo amava fare il bagno ma anche essere asciugato col phon.
Rugiò ( si legge alla francese , ora lo scrivo Rougeau) , come rivela il suo nome, era un gatto rosso. Una mattina vidi tre gatti rossi, allineati su un pergolato . Le tre civette di Ambarabàciccicoccò mi richiamano quell’immagine. Per due giorni la zia pensò che avessi le traveggole perché parlavo continuamente di statuari gatti sul pergolato che lei non riusciva a vedere. Finalmente al terzo giorno i tre compari si degnarono di farsi scorgere e fu salva la mia reputazione. Le tre anime rosse erano state abbandonate nel giardino da una signora che si era trasferita in un’altra città. Rougeau pian piano si fece accarezzare e arrivò in casa. Dopo un iniziale assedio alla Maina, un merlo indiano che in seguito ai miei lunghi tentativi di addestramento riuscì a pronunciare “Maina”, “Marì” ( che soddisfazione! Ma giuro che le parlavo in italiano doc) e Ciccià ( nome del cane), Rougeau si mise l’anima in pace e desistette dalle voraci ambizioni. Imparò presto a coricarsi per terra, ad allungare le zampe per aprire un mobile basso della cucina e a rovesciare la scatola dei croccantini.
Romeo era invece uno dei tre figli di Biòs. Per un paio di anni si comportò come un indolente gattone domestico, fino a quando madre natura lo portò a scoprire il seducente mondo delle gatte e si inselvatichì. Divenne il boss del rione e cambiò pure voce. Che potere hanno le gatte morte innamorate! La voce roca ben si addiceva allo sfregio sotto l’occhio e all’ orecchia mozza, forse trofei di duelli notturni con qualche rivale in amore. A volte lo incontravo per strada e lo chiamavo. Si avvicinava ma non si lasciava più accarezzare. Ne perdemmo le tracce, ma lo ricordiamo sempre con ammirazione per la conquistata libertà di gatto randagio.
Dei gatti della casa della nonna è sopravvissuto Fusarello che gode ancora di ottima salute. Un giorno nascose una biscia viva in un cesto. Di sera andò a scovarla e scatenò un putiferio e un fuggi fuggi generale, simile a quello causato dalla fuiuta del capitone dalle vasche delle pescherie nel periodo natalizio. Un suo fratello, Gri Gri, detto Capucchione, è venuto a mancare poco tempo fa. Un gatto strano. Era talmente timido che stava sempre nascosto dietro una cristalliera. Si lasciava prendere e accarezzare solo dalla zia. Col tempo imparò a vincere la timidezza e a volte entrava pure in cappella e ascoltava (?) la messa. Un giorno si ammalò e mia cugina lo portò dal veterinario. Un’altra zia, trovandolo addormentato, pensò che fosse morto e così lo seppellì in giardino. In verità l’ignaro Capucchione era sotto l’effetto dell’anestesia e mia cugina corse a salvarlo. Dopo la drammatica, non voluta esperienza, il redivivo visse ancora felice e contento a conferma del detto che a volte si può “ nascere sotto una buona stella”.
Quando con la mia famiglia mi trasferii in Liguria, continuai a coltivare il mio feeling felino. Un’unica e selvatica gatta randagia approdò nel giardino di casa e da lei ebbe origine una lunga discendenza.
Ogni giorno Mamma Gatta si avvicinava al balcone della cucina in cerca di qualcosa da mangiare. Ogni sera la aspettavamo e ci impensierivamo se tardava a venire. A lei devo la più naturale lezione di educazione sessuale perché un pomeriggio , sentendola miagolare in modo strano, la vidi mentre partoriva un micetto. Grazie a lei capii che i gatti nascono dal culetto, mentre i bambini continuavano a nascere dalla pancia della mamma, perché gli umani non sono gatti. Beata ingenuità dei miei dieci anni che mi faceva immaginare una straordinaria dilatazione dell’ombelico dal quale uscivano i bebè. Non riuscivo a spiegarmi altrimenti l’utilità di quel buco che i gatti non avevano.
Mamma gatta non tornò più, quindi adottammo i suoi cuccioli. Pallino diventò il raìs del rione. Lo inseguivo quando afferrava per la collottola i micini appena nati, cercando di avere per sé le attenzioni di mamma gatta. Un chiaro esempio di sciovinismo ed egoismo felino. Suo fratello, detto il Grigio, era molto diverso. Aveva un pelo vellutato, color grigio scuro, e grandi occhi giallo-verdi, come il più aristocratico certosino, e soffriva invece di crisi di identità. Divenne l’ inseparabile amico del mio bassotto Dusky. Di sera lo aspettava sullo zerbino del portone e, camminandogli a fianco, se ne andava a dormire con lui nella cuccia. Poi dicono “ cani e gatti…”
Celestina invece era una gattina dolcemente timorosa e molto silenziosa. Mia madre aveva un debole per lei e le parlava di nascosto. Alle 17. 30 Celestina si sedeva sulla scala esterna e aspettava mio padre che rientrava dal lavoro. Riconosceva il clacson dell’auto e gli andava incontro, come fanno i cani. Poi lo seguiva fin sull’uscio di casa. Forse capiva che a breve avremmo cenato e le avremmo dato da mangiare. Chissà! Delle prodezze feline di quegli anni ricordo un’insolita seduta di gatti in semicerchio. Sembravano ipnotizzati, quasi cementati per terra. All’interno dell’ assembramento c’era un riccio. Sì un porcospino ben avvoltolato, che era sconfinato nel mio giardino. Poveretto! Era circondato da una schiera di curiosi cacciatori che ci omaggiavano un giorno sì e uno no di cadaveriche prede ( uccellini, lucertole, insetti, gusci di uova, topolini, a volte pure qualche biscia). Dopo un quarto d’ora di silenzioso appostamento, l’incauto riccio osò fare spuntare il naso. I gatti , sempre seduti, concentrati fissavano la nuova vittima. Non appena il riccio tirò fuori la testa, Celestina con un balzo gli si avventò sopra rimbalzando subito all’indietro, come se avesse ricevuto una scossa elettrica. Liberai la povera bestiola dall’assedio e la riportai nella pineta confinante col giardino.
I gatti sono sempre stati i miei compagni di gioco e stavo ore intere a osservarli, cercando di decifrare il linguaggio della coda e delle orecchie e tentando di imitare i loro miagolii. Circa quattordici anni fa ho deciso di adottarne due, Tigro e Gri Gri. Pure il consorte ha vinto l’iniziale diffidenza e ha imparato a parlottare coi gatti. Mio figlio non va a dormire se prima non ha salutato Gri Gri, che poi quatta quatta si appallottola ai suoi piedi. Che dire? Fanno ormai parte della famiglia, trasmettono affetto, ci si rispecchia un po’ in loro, si acquattano nel trolley quando captano immediate partenze, ci vengono incontro quando rientriamo a casa, ci fanno compagnia con la loro silenziosa presenza, ci coccolano con le fusa e ci logorano con miagolii insistenti. Ma quando si nascondono, ci mancano.
I gatti sono regalmente eleganti, misteriosi e istintivi; scelgono chi amare e non dipendono da nessuno. Sono semplici nei loro bisogni primari ma eternamente cuccioli nell’ entusiasmo e curiosità, affascinanti quando ci osservano e sembrano capire. Interlocutori attenti, muti eppur presenti, abitudinari ma non facilmente addomesticabili .
Un gatto è un gentiluomo. Sotto quel pelo morbido si trova ancora uno degli spiriti più liberi del mondo ( Eric Gurney ) perché Non è facile conquistare l’ amicizia di un gatto. Vi concederà la sua amicizia se mostrerete di meritarne l’ onore, ma non sarà mai il vostro schiavo. (Théophile Gautier ).

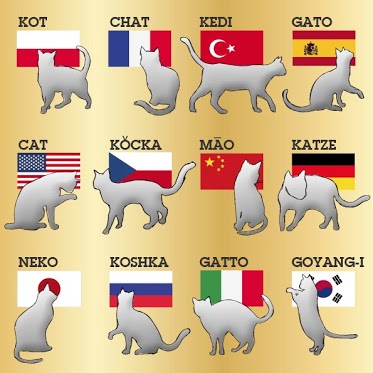
 Follow
Follow