La pastiera è un dolce di antiche e leggendarie origini, tipico della cucina napoletana e del periodo pasquale.
Si narra che in primavera la sirena Partenope emergesse dalle acque del Golfo di Napoli per salutare con canti di gioia le genti della costa. Un giorno sette belle fanciulle furono inviate per omaggiarla con preziosi e semplici prodotti della terra e del lavoro dell’uomo: farina, ricotta, uova ( simbolo della vita), grano, inebriante acqua di fiori d’arancio, seducenti spezie del lontano Oriente e infine zucchero. Partenope pose questi doni ai piedi degli dei che la ringraziarono amalgamandoli magicamente in una pastiera, più dolce del suo canto che incantava uomini e dei.
“L’antica pastiera dall’apparenza casalinga, onesta, sincera, color del legno stagionato, decorata col suo modesto traliccio incrociato di pasta frolla. Intanto è un dolce a metà. Il suo sapore è delicatissimo, composto come è dai chicchi di grano primaticcio ammorbiditi e ammollati, da una buona ricotta, da pezzetti di cedro, umida e fragrante d’acqua di fior d’arancio. È un dolce che sa di primavera e di nozze, di innocenza e d’infanzia, di sole e di serenità, un dolce d’altri e forse più felici, almeno più tranquilli tempi (da “Breviario della cucina napoletana” di Mario Stefanile)
Un dolce talmente squisito, da ridare il sorriso a tutti…
A Napule regnava Ferdinando
Ca passava e’ jurnate zompettiando;
Mentr’ invece a’ mugliera, ‘Onna Teresa,
Steva sempe arraggiata. A’ faccia appesa
O’ musso luongo, nun redeva maje,
Comm’avess passate tanta guaje.
“A Napoli regnava Ferdinando (Ferdinando II di Borbone) che passava le giornate “zampettando”; mentre invece sua moglie, donna Teresa ( Maria Teresa d’Austria) stava sempre arrabbiata. La faccia triste, il muso lungo, non rideva mai, come se avesse passato tanti guai…”( e ci credo… dopo 12 figli e un consorte allegramente zampettante al fianco)
Finchè un giorno la cameriera propose alla regina un dolce nuovo, che piaceva a uomini , donne e bambini. La pastiera addolcì la regina tanto da strapparle un sorriso. Il re esclamò:
“E che marina!
Pe fa ridere a tte, ce vò a Pastiera?
Moglie mia, vien’accà, damme n’abbraccio!
Chistu dolce te piace? E mò c’o saccio
Ordino al cuoco che, a partir d’adesso,
Stà Pastiera la faccia un pò più spesso.
Nun solo a Pasca, che altrimenti è un danno;
pe te fà ridere adda passà n’at’ anno!”
“E che marina! Per farti ridere ti ci vuole una pastiera? Moglie mia, vieni qua, abbracciami. Questo è il dolce che ti piace? E ora che lo so, ordino al cuoco che, a partir da oggi, faccia più spesso ‘sta pastiera. Non solo a Pasqua, chè altrimenti è un danno: per farti ridere deve passare un anno!”
Probabilmente la pastiera, come la conosciamo oggi, nacque dall’estro culinario di un’ignota suora, una delle tante dedite alla preparazione di dolci che allietavano le tavole imbandite di nobili e ricchi borghesi.
I piatti tipici della tradizione napoletana hanno il pregio o il difetto di non rispecchiare mai un’unica ricetta: sono spesso “insubordinati” nelle dosi e negli ingredienti. Non solo, ma ogni famiglia custodisce gelosamente quella variante che rende il piatto speciale e diverso dalla ricetta base. Come ad esempio la pastiera di cui si trovano ricette con uova e ricotta, con crema pasticcera oppure con i tagliolini.
La pastiera mi è cara perché l’ associo a mia madre. Premetto che a tutt’oggi non si cimenta nei dolci se non negli struffoli e nella pastiera, che merita effettivamente un plauso anche per le irregolari strisce incrociate di pastafrolla che sono la sua inconfondibile firma.Mamma dedica un’uscita speciale solo per acquistarne gli ingredienti. Qualche giorno prima di prepararla, mette il grano a mollo nell’ acqua. Il giorno successivo lo cuoce nel latte. E al terzo giorno assisto alla vera resurrezione di mamma. Per soddisfare le richieste di amici e conoscenti, per un giorno intero inforna e sforna dolci di vario diametro, e non vuole essere assolutamente disturbata in un rituale che le appartiene e al quale ha rinunciato solo due volte in vita sua, a causa del terremoto e di un grave lutto familiare.
Alla pastiera sono legati aneddoti indimenticabili nella storia della mia famiglia.Una volta mamma mi telefonò chiedendomi di ritirare la spesa nel negozio di fronte casa sua e la cosa mi parve alquanto strana perché ha sempre, ma sempre fatto tutto da sola. Non appena mi vide, il salumiere esclamò: “Signora, ho preparato le uova per sua madre. Mi scusi , ma a che cosa servono 60 uova?” Ignara di tutto, capii che erano iniziate le grandi manovre pasquali da pastiera. Fu così che anche il salumiere si guadagnò il suo piccolo e dolce tributo pastieresco.
Poiché le specialità gastronomiche di famiglia si trasmettono ancora di generazione in generazione (ebbene sì), per anni le ho chiesto la ricetta della pastiera. In effetti non l’ho mai ricevuta perché lei, come mia suocera, dosa tutto ad occhio e io non potevo permettermi, in tempo e disponibilità, di cimentarmi in un dosaggio da 60 uova.

Finalmente un giorno ho scoperto la ricetta della bisnonna Sofia e ho imparato a cucinarla, finchè un bel giorno mio padre in buona fede osò dire che la mia pastiera era buona quasi come quella di mamma. Non l’avesse mai detto! Si sfiorò un incidente coniugale dopo circa 40 anni di matrimonio perché lei si adombrò; da allora le lasciai volentieri il primato e ancor più volentieri la fatica.Di recente ho ripreso a prepararla con quel piccolo segreto di mamma che la rende speciale.
Per noi tutti, la pastiera rappresenta un po’ l’energia, la sostanza e la dolcezza di mia madre.
Pastiera della bisnonna Sofia.
Ingredienti:
500 g di grano
½ l. di latte
100 g. burro
3 cucchiai di zucchero
1 bastoncino di cannella
100 g di cedro candito tagliato a pezzetti
1 kg di zucchero
1 kg di ricotta
12 uova
buccia di limone grattugiata
un bastoncino di cannella
essenza di fior d’arancio (una fialetta)
Mettere il grano in acqua tiepida e sale per almeno mezza giornata, dopo averlo pulito e sciacquato a lungo.Calarlo in un litro e mezzo d’acqua fredda e lasciarlo bollire (altrimenti comprare il grano già ammorbidito).Cuocere a fuoco lento il grano, già ammorbidito, nel latte, burro, cannella, zucchero e un po’ di sale finchè non si scuoce .
In due terrine battere separatamente i tuorli e gli albumi d’uovo, poi unirli.In un’altra terrina lavorare la ricotta con lo zucchero e versarvi poi il grano cotto nel latte.Aggiungere le uova sbattute, il cedro a pezzetti, il bastoncino di cannella e la fiala di fior d’arancio. Lasciare riposare un po’.
Ingredienti per la crema pasticcera
300g zucchero
2 uova intere + 4 rossi d’uovo
1 l di latte
120 gdi farina o amido
un bastoncino di vaniglia ( in alternativa uso una bustina di vanillina)
buccia grattugiata di limoni verdi .
In una pentola lavorare le uova con lo zucchero.Aggiungere un po’ alla volta la farina continuando a mescolare, poi il latte, la buccia di limone e la vaniglia e amalgamare.Cuocere a fuoco basso mescolando di continuo con un cucchiaio di legno per evitare che la crema si attacchi e si formino grumi. Fare addensare la crema .
Versare la crema nell’impasto precedente, lasciar raffreddare e infine unirvi anche mezzo bicchierino di whisky e qualche goccia di angostura ( variante mia e di mamma che dà un po’ di colore). Mescolare delicatamente. Togliere i bastoncini di cannella.
Pastafrolla ( ma di solito uso quella surgelata).
250-300 g di farina
125-150 g di
zucchero a velo
150 g di burro o strutto
3 tuorli d’uovo
un bicchierino di rum
Mescolare e lavorare la farina,lo zucchero e il burro. Aggiungere i tuorli e il rum, comprimendo delicatamente.Foderare una teglia con la pasta frolla, versare l’impasto della pastiera.Preparare strisce di pasta frolla, larghe1-2 cm, da incrociare sull’impasto.
Cuocere a 180° C per un’ora e un quarto circa. Lasciare raffreddare la pastiera e infine cospargere di zucchero a velo.


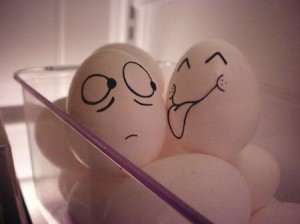

 Follow
Follow
























