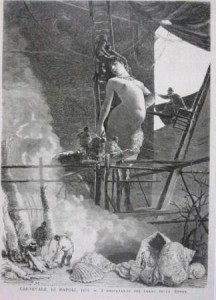Il Miglio Sacro è un itinerario restituito alla città di Napoli che parte dalle antiche catacombe di San Gennaro e arriva alla Cappella del Tesoro di San Gennaro attraversando tutto il Rione Sanità, un quartiere che può riscattarsi con la storia millenaria di un patrimonio artistico ed archeologico poco reclamizzato. Questa zona si può considerare la culla del culto dei morti, celebrato e consacrato attraverso funzioni, devozioni e rituali che fondono religione e magia. Qui sorsero la necropoli greca, in origine fuori dalle mura della città, le catacombe paleocristiane ed infine, in una cava di tufo, l’immenso ossario del cimitero delle Fontanelle che di recente è stato riaperto.
Il Miglio Sacro è un itinerario restituito alla città di Napoli che parte dalle antiche catacombe di San Gennaro e arriva alla Cappella del Tesoro di San Gennaro attraversando tutto il Rione Sanità, un quartiere che può riscattarsi con la storia millenaria di un patrimonio artistico ed archeologico poco reclamizzato. Questa zona si può considerare la culla del culto dei morti, celebrato e consacrato attraverso funzioni, devozioni e rituali che fondono religione e magia. Qui sorsero la necropoli greca, in origine fuori dalle mura della città, le catacombe paleocristiane ed infine, in una cava di tufo, l’immenso ossario del cimitero delle Fontanelle che di recente è stato riaperto.
Tra il Seicento e il Settecento la cava fu utilizzata come cimitero per i poveri e soprattutto  per le vittime della peste del 1656 che a Napoli aveva causato circa 300000 morti e non pochi problemi di igiene e di reperimento di spazi sufficientemente capienti per seppellirli, anche perché le catacombe avevano già accolto le vittime dell’epidemia del 1479. Come riferisce il canonico Andrea De Jorio, verso la fine del Settecento persone abbienti chiedevano di essere sepolte nelle chiese ma, a funerali avvenuti, di notte i becchini trasportavano le salme nelle cave inutilizzate per evitare sovraffollamento nelle chiese.
per le vittime della peste del 1656 che a Napoli aveva causato circa 300000 morti e non pochi problemi di igiene e di reperimento di spazi sufficientemente capienti per seppellirli, anche perché le catacombe avevano già accolto le vittime dell’epidemia del 1479. Come riferisce il canonico Andrea De Jorio, verso la fine del Settecento persone abbienti chiedevano di essere sepolte nelle chiese ma, a funerali avvenuti, di notte i becchini trasportavano le salme nelle cave inutilizzate per evitare sovraffollamento nelle chiese.
Dopo un allagamento della cava, che portò in superficie le capuzzelle ( piccole teste, cioè i teschi) in uno scenario apocalittico, le ossa vi furono ricomposte e furono costruiti un muro e un altare nell’antro, riconosciuto ormai come ossario della città. In seguito all’editto napoleonico di Saint Cloud del 1804, che vietò le sepolture nelle città e  nei luoghi pubblici, nell’ossario furono raccolti anche i resti umani rinvenuti nelle terre sante delle tante chiese napoletane o durante gli scavi archeologici , come in Via Acton nei pressi del Maschio Angioino,oltre le vittime del colera del 1836. Sono visibili decine di migliaia di teschi e ossa lunghe ad eccezione delle due salme intatte e vestite di Filippo Carafa, conte di Cerreto e di Maddaloni, e di sua moglie Margherita.
nei luoghi pubblici, nell’ossario furono raccolti anche i resti umani rinvenuti nelle terre sante delle tante chiese napoletane o durante gli scavi archeologici , come in Via Acton nei pressi del Maschio Angioino,oltre le vittime del colera del 1836. Sono visibili decine di migliaia di teschi e ossa lunghe ad eccezione delle due salme intatte e vestite di Filippo Carafa, conte di Cerreto e di Maddaloni, e di sua moglie Margherita.
Alla fine dell’Ottocento padre Gaetano Barbati coordinò alcuni devoti per riordinare le ossa in cataste e fece costruire la sobria chiesa di Maria Santissima del Carmine nel sito delle Fontanelle. Da allora sorse uno spontaneo e particolare culto popolare per gli ignoti defunti, che consisteva nell’adozione delle anime pezzentelle del Purgatorio, bisognose di cure e preghiere, in cambio di grazie e favori. Questo culto, ancor oggi limitatamente praticato, è una porta rituale tra il mondo dei vivi e dei morti: i morti chiedono ai vivi una preghiera e i vivi, perlopiù donne, si rivolgono alle anime abbandonate che fanno da tramite tra la vita terrena e quella ultraterrena. Il limite tra la fede – tradizioni popolari e la superstizione è sottile, ma i devoti sentono più vicini a loro le anime pezzentelle di umili origini nelle quali ritrovano comuni miserie, sofferenze e solitudini.  L’adottante sceglieva una capuzzella, la puliva e la lucidava, la poneva su un fazzoletto ricamato ed infine, durante visite periodiche, le offriva lumini, fiori e preghiere “A refrische ‘e ll’anime d’o priatorio”. Poi la circondava con un rosario e la adagiava su un cuscino, ornato di pizzi e ricami . Solo dopo questo rituale pare che l’anima purgante apparisse in sogno , richiedendo “refrisco” ( cioè preghiere e cure per essere sollevata dalla sofferenza) e svelando la sua storia personale.
L’adottante sceglieva una capuzzella, la puliva e la lucidava, la poneva su un fazzoletto ricamato ed infine, durante visite periodiche, le offriva lumini, fiori e preghiere “A refrische ‘e ll’anime d’o priatorio”. Poi la circondava con un rosario e la adagiava su un cuscino, ornato di pizzi e ricami . Solo dopo questo rituale pare che l’anima purgante apparisse in sogno , richiedendo “refrisco” ( cioè preghiere e cure per essere sollevata dalla sofferenza) e svelando la sua storia personale.  Se la capuzzella iniziava a sudare, significava che si stava adoprando per intercessioni a favore del devoto o per concedergli la grazia . In realtà l’alto tasso di umidità della cava ancor oggi provoca la formazione di gocce di condensa sui teschi, facendoli sembrare sudati. A questo punto l’animella entrava a fare parte della famiglia e veniva custodita in un tempietto di marmo o di legno, in una teca di vetro, a volte pure in una semplice scatola metallica di biscotti , sui quali si incidevano il nome dell’adottante e l’anno di ricevimento della grazia. Se però non venivano esaudite le richieste, quali guarigioni, matrimoni,vincite al lotto, il devoto poteva rimpiazzare la capuzzella con un’altra, nella speranza che si rivelasse più benevola. Se il teschio non sudava, significava che l’anima pezzentella era in uno stato di sofferenza ed impossibilitata ad elargire grazie, quindi bisognava confidare in entità celesti più potenti. Nel 1969 il cardinale di Napoli Ursi vietò come pagana e superstiziosa questa forma di devozione, frutto della religiosità popolare.
Se la capuzzella iniziava a sudare, significava che si stava adoprando per intercessioni a favore del devoto o per concedergli la grazia . In realtà l’alto tasso di umidità della cava ancor oggi provoca la formazione di gocce di condensa sui teschi, facendoli sembrare sudati. A questo punto l’animella entrava a fare parte della famiglia e veniva custodita in un tempietto di marmo o di legno, in una teca di vetro, a volte pure in una semplice scatola metallica di biscotti , sui quali si incidevano il nome dell’adottante e l’anno di ricevimento della grazia. Se però non venivano esaudite le richieste, quali guarigioni, matrimoni,vincite al lotto, il devoto poteva rimpiazzare la capuzzella con un’altra, nella speranza che si rivelasse più benevola. Se il teschio non sudava, significava che l’anima pezzentella era in uno stato di sofferenza ed impossibilitata ad elargire grazie, quindi bisognava confidare in entità celesti più potenti. Nel 1969 il cardinale di Napoli Ursi vietò come pagana e superstiziosa questa forma di devozione, frutto della religiosità popolare.
Gli oltre 40000 resti, sistemati nei lunghi corridoi del cimitero delle Fontanelle, a volte  formano macabre strutture come quella del Tribunale e della Biblioteca. Quest’ultima ricorda gli scaffali di una libreria, formati da teschi e ossa lunghe, ben allineate e calcificate, che incorniciano l’edicola del Sacro Cuore di Gesù. Inquietante è il Tribunale con le sue tre croci su un Golgota di teschi, dinanzi al quale- così pare- i camorristi convenivano per lugubri rituali di affiliazione. Un’aria decisamente sinistra ha invece il Monacone, la statua decapitata di San Vincenzo Ferrer.
formano macabre strutture come quella del Tribunale e della Biblioteca. Quest’ultima ricorda gli scaffali di una libreria, formati da teschi e ossa lunghe, ben allineate e calcificate, che incorniciano l’edicola del Sacro Cuore di Gesù. Inquietante è il Tribunale con le sue tre croci su un Golgota di teschi, dinanzi al quale- così pare- i camorristi convenivano per lugubri rituali di affiliazione. Un’aria decisamente sinistra ha invece il Monacone, la statua decapitata di San Vincenzo Ferrer.
L’anima purgante più famosa delle Fontanelle è il Capitano, probabilmente spagnolo, che ha aiutato molti devoti . Esistono varie leggende sul Capitano ma la più nota riguarda due sposi. Si narra di una giovane promessa sposa che venerava molto quest’anima pezzentella. Il suo fidanzato, ritenendo che le cure prestate ad ignote ossa fossero inutili, un giorno accompagnò la futura consorte nell’ossario per veder da vicino il teschio. Infilò un bastone nella sua cavità orbitale e con modi provocatoriamente scherzosi lo invitò al matrimonio. Il giorno delle nozze tra gli invitati comparve un carabiniere che nessuno conosceva . Quando lo sposo gli chiese da chi fosse stato invitato, questi rispose che proprio lui l’aveva fatto e, aprendo la divisa, si mostrò in tutta la sua nudità scheletrica provocando la morte di crepacuore dei due sposi. La leggenda vuole che i resti degli sposi siano conservati presso la statua di Gaetano Barbati, mentre si pensa che essi siano stati dipinti sulle pareti delle catacombe di san Gaudioso. Non oso immaginare cosa sia potuto succedere nell’aldilà all’arrivo della promessa e mancata sposa che deve avere fatto una bella sfuriata sia al fantasma del Capitano che allo sprezzante fidanzato.
Altra anima pezzentella , per la quale si nutre particolare devozione, è la sposa Lucia, morta in naufragio col suo sposo o travolta da un’onda mentre lo attendeva su una scogliera. La sua capuzzella è ornata di velo nuziale ed omaggiata di fiori, lumini e suppliche scritte. Si trova però in via dei Tribunali, precisamente nella chiesa delle Anime del Purgatorio ad Arco, dall’ inconfondibile facciata barocca, realizzata da Cosimo Fanzago, adorna di teschi e femori di bronzo. La Chiesa, comunemente detta d’e cape ‘e morte o d’e capuzzelle fu costruita nel 1638 ad opera di una congregazione di nobili che dal 1604 raccoglieva fondi per la celebrazione di messe in suffragio alle anime del Purgatorio. Qui è esposta la tela la “Madonna delle Anime Purganti” di Massimo Stanzione (nel 1635) . Quando la chiesa fu chiusa in seguito al terremoto del 1980, molti devoti chiesero di potere accedere all’ipogeo in quanto spesso chiamati in sogno dalle anime purganti ma poterono riprendere le visite soltanto nel 1992.
 Questo culto così particolare non solo è una sorta di misericordiosa alleanza e complice intesa tra i poveri vivi e i poveri morti per un aiuto reciproco, ma anche un’occasione per riflettere sull’aldilà attraverso i teschi, simboli di contemplazione dei santi nelle opere dei grandi autori, quali Caravaggio, Jusepe de Ribera, El Greco, Van Dick, Georges deLa Tour, Rembrandt.
Questo culto così particolare non solo è una sorta di misericordiosa alleanza e complice intesa tra i poveri vivi e i poveri morti per un aiuto reciproco, ma anche un’occasione per riflettere sull’aldilà attraverso i teschi, simboli di contemplazione dei santi nelle opere dei grandi autori, quali Caravaggio, Jusepe de Ribera, El Greco, Van Dick, Georges deLa Tour, Rembrandt.
Il culto delle anime pezzentelle approda alla consapevolezza che in fondo “all’ àutro munno simm tutte eguale” e “Simm tutt cape ‘e morte”, cioè che “la morte è la completa uguaglianza degli ineguali”, è “una livella” a detta di Totò: ciò che era visibile e rilevante in vita diviene invisibile ed irrilevante nella dimensione sospesa (“queste pagliacciate le fanno solo i vivi: noi siamo seri…apparteniamo alla morte”, proclama l’ombra del netturbino a quella del marchese che disdegnava di essere sepolto accanto a lui) .
Napoli si legge anche tra i vicoli , negli usi e costumi e in ciò che a prima vista non appare, come una metafora tra le righe. Visitare questi luoghi di culto popolare consente di esplorare il mistero, ove si confondono riti sacri e profani, religione e magia. L’iniziale incredulità o scetticismo svaniscono man mano che nel rituale delle anime pezzentelle si riconoscono un generale bisogno di essere ascoltati per ricevere conforto e sollievo, di ascoltarsi nel raccoglimento di una preghiera, per gli altri e per se stessi, di trovare conferme di protezione nei meandri della fede o della suggestione superstiziosa. Alla sensazione di profanare l’intimità della morte subentra la pietosa accoglienza del silenzio delle anime purganti e proprio nelle tenebre, percependo il destino dell’umanità di sempre, si intravede una speranza di redenzione dei vivi e dei morti per scattare in avanti nella vita terrena e ultraterrena.
“Questo guazzabuglio di fede e di errore, di misticismo e di sensualità, questo culto esterno così pagano, questa idolatria, vi spaventano? Vi dolete di queste cose, degne dei selvaggi? E chi ha fatto nulla per la coscienza del popolo napoletano? Quali ammaestramenti, quali parole, quali esempi, si è pensato di dare a questa gente così espansiva, così facile a conquidere, così naturalmente entusiasta? In verità, dalla miseria profonda della sua vita reale, essa non ha avuto altro conforto che nelle illusioni della propria fantasia: e altro rifugio che in Dio.”
(Da “Il ventre di Napoli” di Matilde Serao)
Articoli correlati:
Rione Sanità- le catacombe di Napoli

 Follow
Follow