Nel cortile della chiesa delle Gianchette di Ventimiglia è arrivato l’esemplare extralarge della Venere degli stracci, opera del grande artista contemporaneo Michelangelo Pistoletto, simbolo dell’Arte povera e icona della cultura del consumismo contemporaneo. È stata già accolta in contesti di frontiera e in luoghi di emergenza sociale come l’isola di Lampedusa e il MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di Roma e partirà poi a giugno per Bolzano. Già nell’aprile 2017 su un’aiuola al confine italofrancese di ponte San Ludovico Pistoletto collocò il Terzo Paradiso, una sequenza di massi a forma di otto rovesciato, dove l’anno scorso ricordammo coloro che persero la vita nel tentativo di varcare quel confine.
“Gli stracci non sono solo stoffe, ma quel che resta degli abiti. Dentro ogni straccio è passato almeno una persona. Quindi c’è l’umanità, tutto quello che l’umanità ha vissuto e che rimane come residuo. E la Venere, con la sua bellezza rivolta verso quegli scarti, rigenera la fine.”
Una rigenerazione che a Ventimiglia si fa attiva e partecipativa nel donare nuove appartenenze a chi, in viaggio verso l’ignoto, è troppo spesso reso invisibile dalla perdita della propria identità. Da quest’opera d’arte contemporanea parte un messaggio importante di sensibilizzazione per l’attuale e drammatica situazione delle migrazioni in Europa e nel Mediterraneo. Arte che si fonde con la vita per promuovere responsabilità sociale, dialogo, relazione, un ponte culturale e umanitario in una città che ha trovato in Don Rito una figura di grande spessore per l’impegno nell’accoglienza, nel rispetto e nella cura dei migranti. Grazie a lui persone della società civile, di ogni nazionalità, età ed estrazione socioculturale, si sono attivate come potevano mettendo in pratica quei valori che sono alla base di ogni democrazia.
È bello vedere come a Ventimiglia, che ha una realtà complessa, confluiscano volontari da ogni parte d’Italia e d’Europa. Sì, d’Europa. Voglio ricordare i ragazzi britannici che hanno operato per i piccoli ospiti delle Gianchette, regalandoci poi tutto il materiale rimasto, o i volontari di un’associazione tedesca che si sono adoprati perché le donne nascoste nel fiume potessero lavarsi, e tutti quei ragazzi e volontari francesi che ogni sera distribuiscono pasti e vestiti ai migranti di passaggio. Ricordo anche una giovane insegnante universitaria venuta appositamente dall’America per capire cosa stesse succedendo a Ventimiglia e in Italia con il fenomeno della migrazione. Aveva pianificato le sue ferie per parlare con rappresentanti istituzionali e volontari che operano per e con i migranti in varie parti d’Italia e raccogliere interviste e foto che le servivano per una pubblicazione.
Ventimiglia nel suo piccolo di fatto rappresenta la cultura in trasformazione, cosa che non può dirsi per altre città liguri, ma non dimentichiamo che in fondo arte e cultura sono motori di sviluppo territoriale.
Oltre alla Venere nel cortile della chiesa delle Gianchette ci sono altri stracci intrecciati in una rete da cantiere, anch’essa di scarto che diventa risorsa. L’intreccio consente la visione di un grande planisfero, un mondo a colori per tessere relazioni e veicolare metafore, raccontare un nuovo tessuto sociale in una complementarietà di pieni e vuoti, collegati da un filo alla vela che consente di navigare alla Venere degli stracci. Al centro la riproduzione in carta d’alluminio del Terzo Paradiso, realizzata dai bambini delle scuole: due cerchi piccoli possono unirsi e trasformarsi in uno più grande, perché l’unione è sempre una risorsa e una forza.
Tempo fa scrissi, ricordando un giovane migrante:“Dicono che chi viaggia ha più strade, chi stende le ali e molla tutto si lancia in un’ avventura per allontanarsi dalla propria vita, con un senso di libertà e un brivido di paura. Per allontanarsi sì, ma anche arrivare prima a se stesso, cimentandosi in prove che solo lo sradicamento rende possibili. Forse di fronte alla libertà del mare hai sognato un porto in cui arrivare che valesse tutta quell’acqua da attraversare. Il mare ridimensiona e cambia prospettiva, separa e unisce popoli e terre. Quel viaggio vi ha dato nuovi occhi, per sperare. “Sembra esserci nell’uomo, come negli uccelli, un bisogno di migrazione, una vitale necessità di sentirsi altrove” (Marguerite Yourcenar) e c’è anche tanta bellezza in tutto questo.”
 Oggi riconosco che quest’esperienza è stata straordinaria; chiunque di noi riconosce che ci ha cambiati e arricchiti. Penso alla stazione di piazza Garibaldi della metropolitana di Napoli dove Pistoletto ha collocato le immagini fisse di viaggiatori di ogni età su specchi nei quali si riflettono quelli veri che salgono verso la città sulle scale mobili. Gente che va e viene in una quotidianità che si ripete, in un flusso vario e denso di energia e vissuti. Così ora alle Gianchette nella mostra di foto, video, diapositive, disegni, lettere, articoli di giornale, pietre colorate e nel librone di 13000 nomi di uomini donne e bambini di 50 diverse nazionalità c’è scritta un’importante pagina di storia, ci sono i passi, le testimonianze di un’umanità così umile da renderci partecipi delle loro vite e dei loro fiduciosi sorrisi. Questo è stato il piccolo grande miracolo di Ventimiglia, in un contesto socio culturale non facile, spesso indifferente, a volte chiuso e ostile, ma un miracolo che rigenera, dà speranza e commuove chi l’ha capito. Grazie a quanti lo hanno reso possibile, a tutte quelle 13000 persone in cammino, grazie per averci spronato a trovare nell’emergenza le risorse interiori per uscire da noi stessi, per incontrarvi, sostenervi come potevamo, e conoscervi facendoci sperimentare che la diversità arricchisce davvero nel profondo e che ogni essere umano, con il suo vissuto e le sue speranze, merita rispetto in quanto tale.
Oggi riconosco che quest’esperienza è stata straordinaria; chiunque di noi riconosce che ci ha cambiati e arricchiti. Penso alla stazione di piazza Garibaldi della metropolitana di Napoli dove Pistoletto ha collocato le immagini fisse di viaggiatori di ogni età su specchi nei quali si riflettono quelli veri che salgono verso la città sulle scale mobili. Gente che va e viene in una quotidianità che si ripete, in un flusso vario e denso di energia e vissuti. Così ora alle Gianchette nella mostra di foto, video, diapositive, disegni, lettere, articoli di giornale, pietre colorate e nel librone di 13000 nomi di uomini donne e bambini di 50 diverse nazionalità c’è scritta un’importante pagina di storia, ci sono i passi, le testimonianze di un’umanità così umile da renderci partecipi delle loro vite e dei loro fiduciosi sorrisi. Questo è stato il piccolo grande miracolo di Ventimiglia, in un contesto socio culturale non facile, spesso indifferente, a volte chiuso e ostile, ma un miracolo che rigenera, dà speranza e commuove chi l’ha capito. Grazie a quanti lo hanno reso possibile, a tutte quelle 13000 persone in cammino, grazie per averci spronato a trovare nell’emergenza le risorse interiori per uscire da noi stessi, per incontrarvi, sostenervi come potevamo, e conoscervi facendoci sperimentare che la diversità arricchisce davvero nel profondo e che ogni essere umano, con il suo vissuto e le sue speranze, merita rispetto in quanto tale.
L’evento è stato promosso dalla Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo, Ventimiglia CONfine Solidale , con la collaborazione di Cittadellarte- Fondazione Pistoletto, del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte contemporanea, dell’Associazione Pigna Mon Amour di Sanremo e di spazio5 di Bolzano.
La mostra è aperta dal 18 maggio fino al 20 giugno presso la chiesa delle Gianchette ( venerdì- sabato – domenica dalle 10.00 alle 20.00)
Articoli correlati:
“Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato” (proverbio africano).



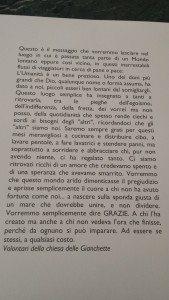










 Follow
Follow

















